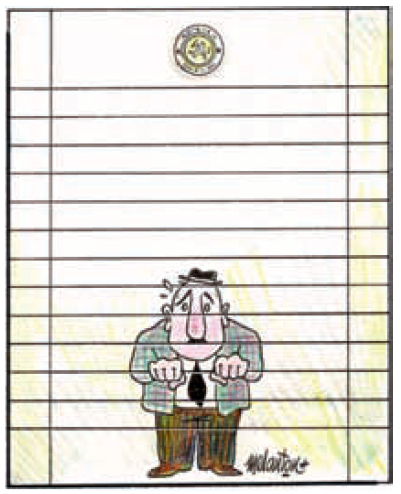MANGIAMO ANCORA PANE E PROVERBI?
di Antonio Mele / ‘Melanton’
Molte piccole cose vissute si rivelano grandi e straordinarie quando improvvise riaffiorano dalla nostra memoria, in un momento qualsiasi di un giorno qualsiasi.
Sono il segno indelebile delle nostre vite forse troppo presto accantonate. Infanzie e adolescenze di cui prendiamo quasi sempre tardiva consapevolezza, stemperate peraltro dallo specchio deformante del tempo e della nostalgia, e tuttavia intensamente energetiche e illuminanti.
I proverbi, per esempio. In giorni lontanissimi, eppure così carnalmente vivi da sentirne ancora il profumo, non ricordo un solo momento di conversazione, qualunque fosse l’oggetto e la circostanza, senza che mio padre ne tirasse fuori uno – folgorante e incisivo – dal suo fascinoso repertorio lessicale.
Con sintesi perfetta, esso serviva magistralmente a rimarcare di volta in volta un pensiero etico o filosofico, assumendo un’impareggiabile e carismatica funzione di non banale ed anzi elevatissimo insegnamento.
Si può dire che in casa nostra abbiamo mangiato pane e proverbi più di ogni altra vivanda.
E anche io, quasi senza accorgermene, continuo a dispensare lo stesso “cibo per l’anima”, rispettandolo peraltro come il simbolo più quotidiano e solenne della millenaria civiltà contadina, alla quale mi onoro di appartenere.
In un’epoca come quella contem- poranea, esasperatamente caratteriz- zata da una comunicazione tanto urlata e tambureggiante quanto fredda e impersonale, perfino la più debole e sconosciuta delle massime popolari avrà sempre facile vittoria sul più sofisticato slogan pubblicitario o sul più intellettualoide modo di dire, per quanto abilmente costruito.
La storia, come diceva qualcuno, non s’inventa in un giorno.
Quello che più meraviglia è l’immarcescibile resistenza al tempo di queste veraci pillole di saggezza – specialmente quelle proposte nella palpitante forma vernacolare – che al momento opportuno riemergono d’istinto dai nostri sopiti ricordi.
È pur vero che le globalizzanti e spesso dissacratorie contaminazioni dell’era tecnologica stanno profondamente incidendo sul costume sociale, proponendo alternativi (e non sempre migliorativi) modelli esistenziali, ma mi piace pensare che le vecchie care “sentenze” dei nostri antichi maestri di famiglia resteranno ancora a lungo sulla bocca e nel cuore di molti.
“Lu purpu se coce cu l’acqua soa stessa!” (Il polpo si cuoce con la sua stessa acqua!) ammoniva mio padre, a fronte di una qualche nostra giovanile e malaccorta iniziativa, o semplicemente per richiamarci alla prudenza, e al rispetto delle imperanti regole morali.
E quando la nostra, non dico disubbidienza, ma naturale ed esuberante curiosità di scoprire il mondo, ci portava – nonostante i consigli o divieti – ad avventurarci in azioni ritenute trasgressive o troppo “audaci”, con sguardo fra il rassegnato e il complice, eccolo che rispolverava l’immancabile “Quandu lu ciucciu nu bbole bbiva, è inutile fischià!” (Quando l’asino non vuole bere, è inutile fischiare [per esortarlo]).
Erano tempi in cui – come costantemente mi ricorda “lu Toniu de la Rosa”, mio antico e caro compagno di giochi – in molte case si faceva fatica a combinare il pranzo con la cena, e spesso ci si doveva accontentare di un umile piatto di pisieddhi cu li mammuni (piselli degradati da larve e parassiti), se non addirittura di mammuni cu li pisieddhi…
In questo contesto di diffusa privazione e spesso di autentica miseria, la nostra famiglia poteva considerarsi privilegiata, non mancando fortunatamente dei primari beni di sussistenza.
E tuttavia, se qualcuno di noi faceva i capricci, e si mostrava un po’ schizzinoso nel mangiare le pietanze accuratamente preparate fin dalle prime ore del mattino, all’affettuosa severità di nostro padre si poteva aggiungere anche quella della piccola e “terribile” nonna Anna, con un’altra metafora di carattere zoologico: “Lu porcu bbinchiatu vota la pila sottassusu!” (il maiale sazio ribalta la vasca [del pastone] sottosopra!).
Morta un mese prima che compisse i cento anni, madre di undici figli, analfabeta e sapientissima, nonna Anna era, come molte altre donne di casa dell’epoca, la governante assoluta del bilancio familiare e dell’economia domestica. Non a caso, uno dei suoi ricorrenti tormentoni – spesso buttato lì, senza apparente motivo, ma a costante monito per tutti – era il mitico “Sparagna la farina quandu la mattra è china…” (Risparmia la farina quando la madia è piena…”).
Non si sfuggiva a quei perentori comandamenti.
Tutto era già scritto da secoli, e cadenzato in un ordine ed una disciplina che non apparivano né erano mai autoritari. Che non venivano subiti, ma condivisi. In un’atmosfera comunque affabile, scevra da turbamenti, e sempre segnata da un senso civilissimo di massimo e reciproco rispetto.
Nessun confronto è possibile con la civiltà di oggi. Che è ancora tutta da scrivere, e da cadenzare.
Se sarà migliore o peggiore di quella che la nostra generazione ha vissuto, è troppo presto per dirlo. Certo è che, nonostante gli immancabili affanni e sofferenze, comuni ad ogni vita, in quel tempo abbiamo avuto in dono una vita davvero straordinaria.
Il senso del rispetto, dicevamo. E della dignità dovuta.
Anche noi bambini eravamo considerati “persone”. Con il nostro preciso ruolo. I nostri doveri.E i nostri diritti. Un fatto non da poco, credo. Sul quale, con la mente e il cuore di oggi, varrebbe la pena di soffermarsi a riflettere.
C’era una specie di gioco, a tale proposito, che potrebbe considerarsi esemplare.
Forse non tutti ne conservano memoria, o non l’hanno vissuto allo stesso modo come nella nostra famiglia.
Era un diversivo, premuroso e intriso di delicatezza, che le donne di casa mettevano in atto con i più piccoli, quando questi impicciavano un po’ le tante faccende da sbrigare. Mi pare che si chiamasse “lu ntartieni” (voce dialettale che sta per “trattenere”) o anche, per renderlo più prezioso e affascinante, “lu ntartieni d’oru”.
Serviva ad allontanare con grazia il piccolo “importuno”, mandandolo da un’altra persona della famiglia, magari meno impegnata nella stanza attigua, con l’incarico di farsi dare, appunto, l’immaginario “ntartieni”.
Quando succedeva, il bambino si sentiva felice e orgoglioso di questa incom- benza.
Così caracollava sveltamente fino a raggiungere la destinataria (io venivo indirizzato quasi sempre alla zia Ninetta), la quale ottemperava divertita alla richiesta, distraendo e trattenendo con sorrisi, racconti e biscottini il piccolo messaggero, ben presto dimentico dell’incarico ricevuto, e circondato di coccole.
Se questa, a suo modo, non è poesia… Non credo, infine, che i padri, e soprattutto le mamme, le nonne o le zie di oggi abbiano meno amore e fantasia di quelle di ieri. Forse abbiamo avuto troppa fretta e fatto un po’ di confusione nel costruire il mondo che abbiamo costruito negli ultimi trenta o quarant’anni.
Di quel patrimonio di tempo che avevamo sono rimasti ormai solo pochi spiccioli (Sparagna la farina…), che non ci permettono neppure di stare con noi stessi, figuriamoci con gli altri.
È come se avessimo le lancette dell’orologio costantemente puntate alla schiena. È tardi! È tardi! Correre! Correre! Somigliamo sempre più al Bianco Coniglio di Alice nel Paese delle meraviglie.
E tutte quelle paure, e timori, e ansie, e paranoie?… Forse “li mammuni” nei piselli di ieri ci spaventavano meno dei valori appena fuori norma del colesterolo di oggi. O di quel chiletto di soprappeso che bisogna assolutamente eliminare, per apparire più sani e più belli.
Forse abbiamo voluto stravincere la fame, e per rivalsa immagazziniamo troppi e grassi alimenti – possibilmente precotti, premasticati e predigeriti – anziché, di tanto in tanto, un po’ di pane e proverbi.
Forse, inconsciamente e disperatamente, stiamo correndo da una parte all’altra alla ricerca di quel fantastico e misterioso “ntartieni d’oru”.
Ma nessuno sa più cosa sia. Neanche la televisione ne ha mai parlato.
E poi, non è neppure quotato in Borsa.